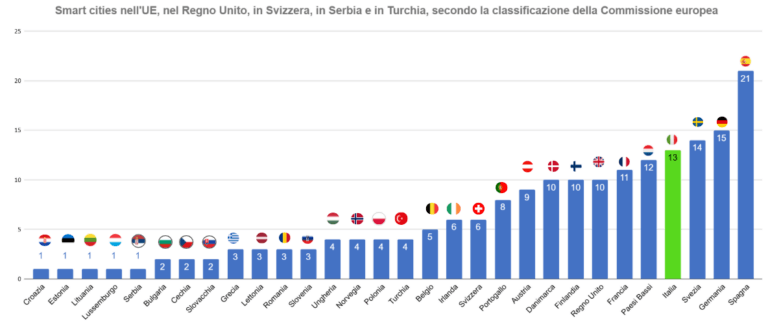Gli studi sulla neurobiologia vegetale, al momento, sono di natura solo speculativa, esplorativa, o sono già indirizzati a qualche applicazione in ambito tecnologico?
È una disciplina di ricerca di base, ma esistono delle applicazioni pratiche su due diversi ordini di argomenti – risponde Stefano Mancuso, direttore del Laboratorio internazionale di Neurobiologia vegetale -. Il primo riguarda lo sfruttamento delle conoscenze ottenute per la costruzione di robot ispirati alla fisiologia vegetale, il secondo confluisce in progetti che invece riguardano l’interpretazione dei segnali elettrici generati dalle piante: gli stimoli prodotti dall’ambiente vengono tradotti in input che, pur essendo più lenti e meno frequenti di quelli del regno animale, sono in grado di riportare anche variazioni di stato minime. Riuscire a decodificare questi segnali significa aprire la strada all’utilizzo delle piante come veri e propri sensori viventi. Oggi si parla tanto di Internet of Things e Smart City. La nostra idea è esattamente all’opposto dell’approccio che va per la maggiore. Perché per raccogliere elevate quantità di dati dovremmo installare ovunque dei device quando abbiamo già a disposizione, e dappertutto, le piante, che sono per natura ricche di sensori chimici, fisici e ambientali?
Ci sono specie più adatte a questo scopo?
Di solito gli alberi sono più facili da gestire, ma non tanto per qualche caratteristica peculiare sul piano dei ricettori e dei sistemi di trasmissione, che sono abbastanza simili a prescindere dalle specie, quanto per la robustezza meccanica che occorre per ospitare il black box su cui far convergere i segnali.
Come è strutturata la vostra organizzazione e chi sostiene l’attività?
Il nostro laboratorio conta 24 persone, quasi tutte ingaggiate a progetto. E anche se siamo leader mondiali in questa specifica disciplina dobbiamo affrontare i soliti problemi della ricerca italiana, con lo Stato che non fornisce alcun aiuto. Spendiamo ogni anno circa 1,2 milioni di euro, che copriamo innanzitutto autofinanziandoci grazie allo spin off dell’Università di Firenze PNAT, startup all’interno della quale sviluppiamo diversi oggetti che provengono dalla ricerca e che offriamo al mercato. Dopodiché ci procuriamo risorse tramite progetti internazionali, fondazioni bancarie e pochi privati, non italiani. Per fortuna possiamo contare su un forte network globale.
Ovvero?
Collaboriamo con Parigi 7, l’università di Bonn, l’Accademia delle Scienze in Cina e l’università di Kitakyshu, dove abbiamo aperto una sede estera che rappresenta un’esperienza da replicare. In pratica abbiamo dato vita a un laboratorio di ricerca sostenuto da diverse aziende private che possono esercitare un diritto di prelazione sui brevetti che registriamo. Se le imprese non sono interessate, il ricercatore che ha sviluppato l’innovazione ha la facoltà di far partire una startup. In quattro anni questo meccanismo ha prodotto un giro d’affari superiore ai 25 milioni di euro.
Qual è il futuro di questa disciplina?
È un campo che ha potenzialità enormi rispetto alla capacità di sviluppare nuove tecnologie: può spalancare ambiti applicativi mai esplorati per la robotica, le scienze dei materiali, le reti, l’analisi dei dati, ma anche per l’ingegneria gestionale.