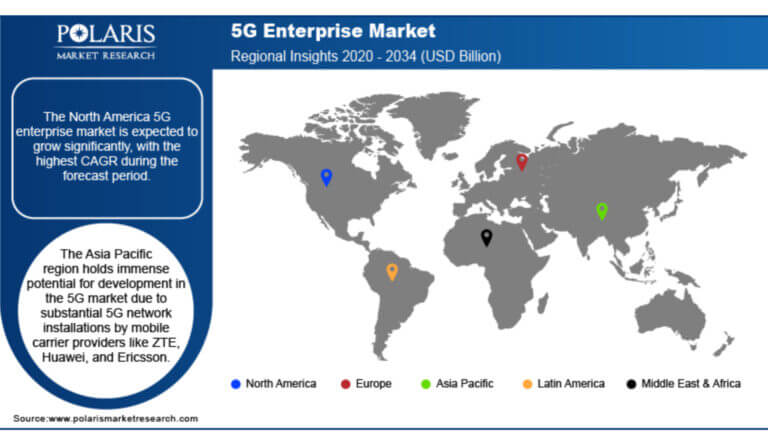Ogni giorno creiamo un quantitativo straordinario di dati. L’ultima stima è di 2,5 “quintilioni” di bytes al giorno: un dieci seguito da diciotto zeri nella scala americana dei grandi numeri (trenta zeri in quella europea). Sono numeri talmente tanti che ci siamo accorti che il 90% del totale dei dati creati nella storia del nostro pianeta sono stati generati negli ultimi due anni. E ancora non abbiamo visto niente, perché l’Internet of Things è di là da venire: 26 miliardi di oggetti connessi con un indirizzo Ip unico, 250 milioni di automobili intelligenti, miriadi di sensori di vario genere che comunicano ininterrottamente tramite reti ad alta velocità. Un quantitativo soverchiante di flussi di dati provenienti da conversazioni M2M, machine-to-machine, che però ci riguardano molto da vicino.
Sopra a tutto questo, un cambiamento radicale negli usi e nelle abitudini della nostra società. La digitalizzazione dei processi documentali finora realizzati su carta sta lasciando lentamente spazio a nuove strutture di dati native dell’ambiente digitale. Le informazioni non vengono più create sotto forma di documenti statici, che nell’epoca del digitale non hanno più senso, ma diventano liquidi, flussi di informazione multidimensionali da analizzare con algoritmi che “pescano” le cose importanti di volta in volta.
Questo vuol dire cambiare radicalmente i processi e spesso anche gli attori di qualunque attività. Un esempio di “disruption” provocata dal digitale? Basta pensare all’uso della carta per le transazioni economiche: eliminando le banconote con i bit si possono costruire sistemi di pagamento più flessibili, azzerare i costi della gestione del contante, innovare in modo sempre più dirompente (pagamenti contactless, oppure online, o fatti con il cellulare direttamente tra privati e al di fuori dei circuiti bancari) sino ad arrivare a negare la necessità della stesse banche centrali (con i BitCoin). Quando il documento, cioè in questo caso la cartamoneta, diventa tutta digitale, cambia tutto.
I dati da soli però non bastano. «Devono essere strutturati in maniera tale da rappresentare delle informazioni – spiega Svetlana Sicular, analista di Gartner – e poi queste, solo quando vengono messe in un contesto adeguato, possono diventare conoscenza che può essere analizzata e quindi azionata». Per questo creare semplicemente un Pdf da un documento cartaceo non basta. La trasformazione sta nella differente natura della struttura dei dati, oltre che nella loro quantità e varietà. Non ci sono solo i Big data. Le aziende e i privati vivono in realtà di piccoli set di dati. Certo, da un lato con il cloud le aziende, anche piccole, possono avere accesso alle risorse di calcolo necessarie per fare elaborazione su grandi flussi di dati: uno scenario che la Internet of Things rende sempre più probabile. Dall’altro lato però le Pmi hanno in realtà sempre più bisogno di conoscere meglio i “Little data” che raccolgono ogni giorno sul mercato. Per capire i bisogni dei loro clienti, ma anche per capire il funzionamento dei propri apparecchi (prevedendo magari i malfunzionamenti) e per costruire una logistica che consenta pianificazioni automatiche e adattive. Con algoritmi che imparano da soli quando “muovere” la catena considerando diversi fattori che hanno impatto sulla produzione.
È l’industria 4.0, che sta tutta nella capacità di connettere tutto e raccogliere e analizzare i dati in maniera appropriata: per questo figure come i laureati in Scienza dei dati (un corso di laurea che sta nascendo in questi mesi) stanno diventando la risorsa strategica più importante per le aziende di qualsiasi dimensione. Le nostre aziende dovrebbero chiedersi: quanti ne assumeranno nei prossimi due anni?
Invece, per i privati, soprattutto in Europa, è il quadro normativo che sta cambiando. L’Unione europea ha lavorato per cinque anni alla creazione di un nuovo regolamento che consenta di tutelare la privacy delle persone: la precedente normativa di metà anni novanta non poteva sapere che sarebbero arrivati il cloud e i social media, veri e propri magneti per la privacy delle persone. Adesso l’Ue ha approvato (manca ancora solo un passaggio tecnico nella plenaria del Parlamento europeo) il nuovo regolamento general Data Protection Regulation (GDPR) che obbliga le aziende europee e straniere che toccano i dati dei cittadini europei a mettere in piedi un insieme di garanzie e limiti per la raccolta e la gestione dei dati, con una nuova authority e l’inedita figura di un responsabile aziendale dei dati.
I poteri sanzionatori sono significativi (fino al 4% del giro d’affari mondiale dell’azienda in violazione), ma rimane il dubbio che una simile normativa, inquadrata come regolamento e non come direttiva, che cioè richiede leggi di attuazione nei singoli paesi poiché non si applica immediatamente, possa essere poco efficace.
Sullo sfondo della vita dei dati, che vengono prodotti, raccolti, elaborati e infine distrutti in maniera più o meno sicura e definitiva, c’è anche un altro scenario. L’informazione digitale è per sua natura indifferente allo strumento che la contiene e può essere aggregata in modi e per scopi più diversi. Anche per la sicurezza e la sorveglianza globale. Che può diventare un Grande fratello difficile da accettare, soprattutto quando viene messo in funzione da un altro Stato. Per questo è stata amara la scoperta che, oltre ai malintenzionati, in rete ci sono in realtà anche i sistemi di sorveglianza globale che spiano le persone, le aziende e gli stessi governanti europei (Italia compresa). Sistemi di sorveglianza statunitensi e britannici, come ha rivelato Edward Snowden, piccolo ingranaggio del sottobosco dello spionaggio che si è messo di traverso e ha creato una delle più grandi falle nella grande macchina per la raccolta dei dati.
La sorveglianza globale è stata vittima del suo stesso successo. Forse perché, come diceva l’attivista Steward Brand, “Information wants to be free”. E quella digitale, molto più efficiente di quella analogica, lo vuole ancora di più.